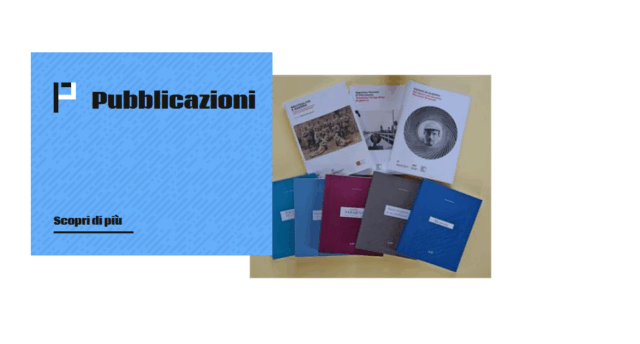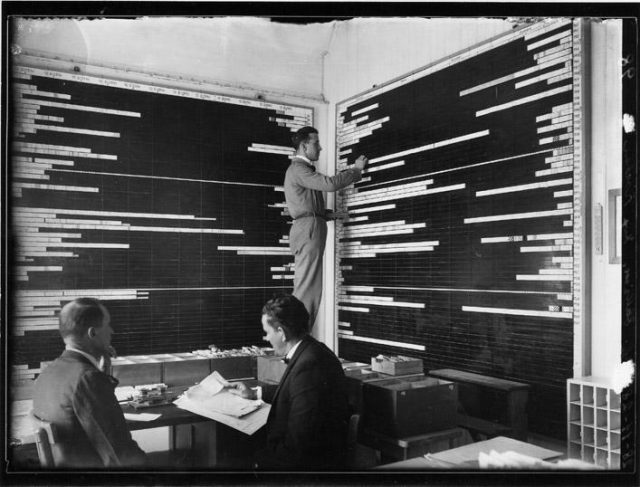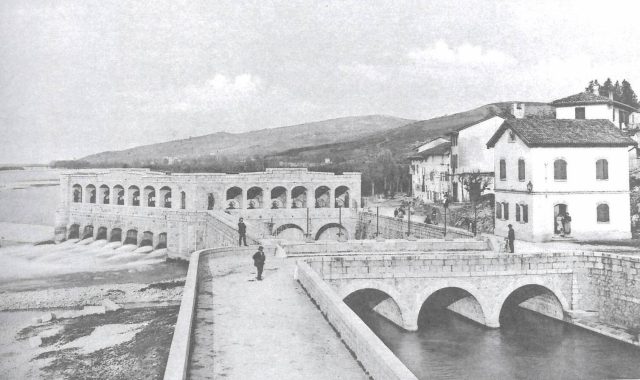L’anima poetica di Walter Dusatti
di Pier Maria Miniussi
Walter Dusatti, Le parole de dentro, Ronchi dei Legionari, Consorzio Culturale del Monfalconese, 2025
Chi oggi prendesse in mano una delle prime copie de “La Cantada”, faticherebbe a riconoscere la rivista che da settant’anni accompagna il Carnevale monfalconese: più che dal formato gigante, dalla carta e dall’impaginazione, che le fanno assomigliare ad un quotidiano del tempo, sarebbe disorientato dai contenuti dei testi, seriosi per non dire intellettualistici e quasi tutti in italiano, e dalla mancanza delle vignette, punto di forza della “Cantada” di oggi. Su quelle pagine fanno eccezione le vivaci strofette in bisiaco di un giovane Walter Dusatti (Carneval, I sogni de Gildo, La maldicenza), che già dimostrano una felice disposizione per composizioni più complesse ed articolate della lirica breve.